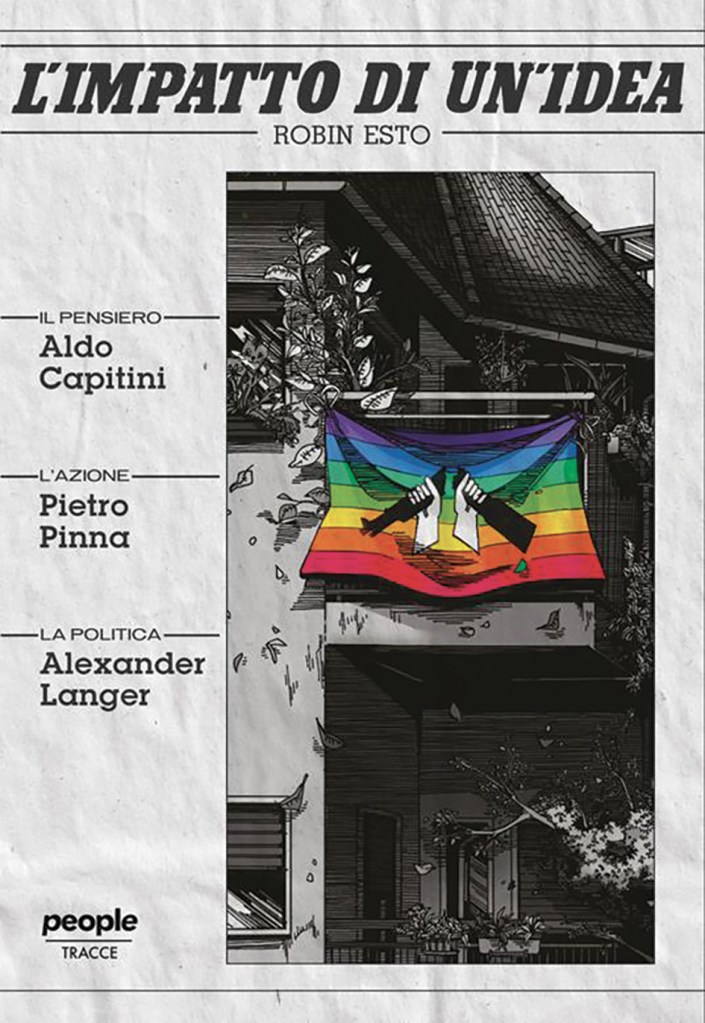Quello che resta, il libro di poesie di Marta Casadei: un dolce grido a Dio sulla morte, sulla vita
«Nella morte ci apriremo a ciò di cui abbiamo vissuto sulla terra».
(Gabriel Marcel)
di Andrea Musacci
Non è fresco di stampa il libro di poesie di Marta Casadei (romagnola di nascita, ferrarese d’adozione), dal titolo Quello che resta (Ed. La Carmelina, con prefazione di Piero Stefani), dedicato alla morte delle persone care, in particolare alla memoria del marito scomparso. Ha due anni di vita ma richiede – per chi ancora non l’ha letto – un’avvertenza: per comprenderlo non è necessario aver perso il proprio amato o la propria amata, ma aver amato. E chi non ha mai avuto la grazia di amare una persona in maniera speciale, l’auspicio è che questo libro apra l’anima preparandola a quella bellezza che rende ancora più cruda la domanda sul perché contenga in grembo il germe della morte.
«TI PREGO, NON ANDARE»
«La vita divorava gli anni» e, invece, più si va avanti più il velo si discosta e con più accecante consapevolezza si comprende che gli anni «divoravano la vita», scrive Casadei. Dopo la perdita del marito – sono sue parole – «sono rimasta sola e sbigottita / con la tua assenza dura, sconsolata». «Tutto qui: / tutto quello che rimane / di una vita sta dentro una valigia»; ma è un mentire, il suo, dettato dalla desolazione: la vita non può stare in una culla, non starà mai in una bara, né in una definizione. Figuriamoci in una valigia.
La mancanza è vuoto, nuda assenza, eremitaggio in una casa che pare sconsacrata, solitudine non desiderata. Il giogo, le spalle lo sentono troppo pesante: «Fino a quando / mi stringerà questa amarezza / questo rimpianto inconsolato e sordo», è la domanda. Rimpianti e rimorsi sono spine nella carne: «non ti ho difeso abbastanza», «non ho creduto abbastanza»; pesano le «consolazioni sperperate». Ma finché, una a una, quelle spine non le si toglie, non ci si potrà aprire all’avvenire, alla lode, alla benedizione. Fino a quel momento, «ancora tutto accade come sempre, / si vegli o dorma, / tutto senza stupore, prevedibile». La realtà diviene inconsistente; anzi, assurda: «cosa ci faccio qui da sola?», che potrebbe essere scritto anche come interrogativo sul senso ultimo dell’esserci (“cosa ci faccio qui?”).
La terra non è lieve – come nel laico augurio a chi se ne va – ma il suo peso «ti copre», a te «che sei inciampato nella morte». E lei rimane sola, «a inaridire», resta «impigliata nella vita», come l’accappatoio in quel gancio, pezzo di feriale memoria. «Ti prego, non andare», scrive Marta: e mi viene, per contrasto, in mente il «Tu non morirai» di Gabriel Marcel.
«VENGA PRESTO LA LUCE»
Poi la luce inizia a filtrare dalle finestre, e ciò non avviene in un momento preciso: «cerco / di ritrovare il senso delle cose / o una ragione / qualunque, nuova». È un primo tentativo, pur nel suo fallimento, di arrivare a una «memoria pacificata».
E qualche pagina dopo: «Voglio farmi un regalo / oggi, una cosa nuova, uscire / dove la vita pulsa nelle strade». Ma il mondo e i suoi abitanti sono ancora senza volto, sfocati, spigoli contro cui sbattere, estranei su terre di nessuno, di certo non di Marta, «sperduta / in un filo di terra straniera». Marta che è ancora non attesa, ancora senza attesa. Attesa che è mancanza, ma protesa con lo sguardo all’avvenire. «Fammi sentire che ci sei», anche se «sei l’altrove»; come a dire: senza l’altro non mi salvo dalla tentazione del nulla. Da qui, «una gioia di lacrime improvvisa», il necessario perdono di sé.
Questo libro è una lode all’amore che è stato, e che non può non durare in eterno. Una lode all’amore piccino, fatto di minuscoli frammenti, di levità, debolezze, scambi quotidiani di fiato e miserie; insomma, del pane del cuore. E quell’amore nascosto, timido, discreto, geloso solo di sé e della propria pudicità, ora viene esibito in questi versi “impudici”. Ma è una “sfrontatezza”, quella di Marta Casadei, talmente innervata di dolcezza che solo una posa richiede: quella di chi si china per meglio sentirne il sussurro, di chi si siede e tace. Di chi si inginocchia davanti al Mistero che Dio apre.
E allora, «venga presto la luce», vieni Spirito d’amore.
Pubblicato sulla “Voce di Ferrara-Comacchio” del 27 febbraio 2026
Abbònati qui!