Il 1° novembre 2009 ci lasciava la poetessa milanese: una vita in perenne tensione tra il dolore e la ricerca pura di una bellezza eterna. Sempre in bilico tra malattia mentale, scrittura e fede
di Andrea Musacci
 “Quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita”: si potrebbe sintetizzare con queste sue parole l’esistenza unica, divina e tremenda, di Alda Merini, deceduta esattamente 10 anni fa, il giorno di Ognissanti. Figlia tanto adorata quanto maltrattata, donna che ha fatto della poesia molto più che una scrittura, un modo di esprimere tanto il delirio e le piaghe interiori quanto quella grazia da lei sempre accolta. Donna afflitta da quello stesso male che la accomunava a Clemente Rebora – vittima, come gli diagnosticarono, di “mania dell’eterno” – e Dino Campana, solo per citarne due. Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano. Il padre Nemo Merini, con lei molto affettuoso, è impiegato di concetto presso le assicurazioni, la madre, Emilia Painelli, è casalinga e donna molto severa. Alda è secondogenita di tre figli, tra Anna, nata il 26 novembre 1926, ed Ezio, nato il 23 gennaio1943. Esordisce come autrice a 15 anni, attraverso un’insegnante delle medie viene presentata ad Angelo Romanò che, apprezzandone le doti letterarie, la mette in contatto con Giacinto Spagnoletti, il quale divenne la sua guida, valorizzandone il talento. Nel 1947, viene per la prima volta internata per un mese nella clinica Villa Turro a Milano, dove le diagnosticano un disturbo bipolare. Spagnoletti sarà il primo a pubblicarla nel 1950, nell’“Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949”. Terminata la difficile relazione con Giorgio Manganelli, il 9 agosto 1953 sposa Ettore Carniti, operaio e sindacalista, in seguito proprietario di alcune panetterie di Milano. Nasce in quello stesso anno la prima figlia, Emanuela, mentre nel ’57 nasce la secondogenita Flavia. Anni dopo, fra il ’64 e il ’72, verrà internata nell’Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”, con alcuni ritorni in famiglia, durante i quali nascono altre due figlie, Barbara e Simona, che saranno affidate ad altre famiglie. Si alterneranno in seguito periodi di salute e malattia, probabilmente dovuti al disturbo bipolare. Nel 1979 riprende a scrivere, dando vita ai testi poi raccolti in “La Terra Santa”. Nel luglio del 1986 fa ricorso al reparto di neurologia dell’Ospedale di Taranto. Nello stesso anno riprende a scrivere e pubblica “L’altra verità. Diario di una diversa”, il suo primo libro in prosa. Soprattutto negli anni 2000 rivive un periodo mistico, dal quale escono diversi libri e antologie di poesie. Muore il 1° novembre 2009, all’età di 78 anni, a causa di un tumore osseo all’Ospedale San Paolo. Dopo l’allestimento della camera ardente, aperta ii giorni successivi, i funerali di Stato sono stati celebrati il 4 novembre nel Duomo di Milano. Oggi Alda Merini è tumulata al Cimitero Monumentale di Milano, nella Cripta del Famedio.
“Quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita”: si potrebbe sintetizzare con queste sue parole l’esistenza unica, divina e tremenda, di Alda Merini, deceduta esattamente 10 anni fa, il giorno di Ognissanti. Figlia tanto adorata quanto maltrattata, donna che ha fatto della poesia molto più che una scrittura, un modo di esprimere tanto il delirio e le piaghe interiori quanto quella grazia da lei sempre accolta. Donna afflitta da quello stesso male che la accomunava a Clemente Rebora – vittima, come gli diagnosticarono, di “mania dell’eterno” – e Dino Campana, solo per citarne due. Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano. Il padre Nemo Merini, con lei molto affettuoso, è impiegato di concetto presso le assicurazioni, la madre, Emilia Painelli, è casalinga e donna molto severa. Alda è secondogenita di tre figli, tra Anna, nata il 26 novembre 1926, ed Ezio, nato il 23 gennaio1943. Esordisce come autrice a 15 anni, attraverso un’insegnante delle medie viene presentata ad Angelo Romanò che, apprezzandone le doti letterarie, la mette in contatto con Giacinto Spagnoletti, il quale divenne la sua guida, valorizzandone il talento. Nel 1947, viene per la prima volta internata per un mese nella clinica Villa Turro a Milano, dove le diagnosticano un disturbo bipolare. Spagnoletti sarà il primo a pubblicarla nel 1950, nell’“Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949”. Terminata la difficile relazione con Giorgio Manganelli, il 9 agosto 1953 sposa Ettore Carniti, operaio e sindacalista, in seguito proprietario di alcune panetterie di Milano. Nasce in quello stesso anno la prima figlia, Emanuela, mentre nel ’57 nasce la secondogenita Flavia. Anni dopo, fra il ’64 e il ’72, verrà internata nell’Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”, con alcuni ritorni in famiglia, durante i quali nascono altre due figlie, Barbara e Simona, che saranno affidate ad altre famiglie. Si alterneranno in seguito periodi di salute e malattia, probabilmente dovuti al disturbo bipolare. Nel 1979 riprende a scrivere, dando vita ai testi poi raccolti in “La Terra Santa”. Nel luglio del 1986 fa ricorso al reparto di neurologia dell’Ospedale di Taranto. Nello stesso anno riprende a scrivere e pubblica “L’altra verità. Diario di una diversa”, il suo primo libro in prosa. Soprattutto negli anni 2000 rivive un periodo mistico, dal quale escono diversi libri e antologie di poesie. Muore il 1° novembre 2009, all’età di 78 anni, a causa di un tumore osseo all’Ospedale San Paolo. Dopo l’allestimento della camera ardente, aperta ii giorni successivi, i funerali di Stato sono stati celebrati il 4 novembre nel Duomo di Milano. Oggi Alda Merini è tumulata al Cimitero Monumentale di Milano, nella Cripta del Famedio.
L’INFERNO…
“Mi misero a letto, ma nessuno mi carezzò la fronte. Anzi mi legarono mani e piedi”, racconta lei stessa della prima volta che la portano in manicomio. Ed emerge così fin da subito in quale inferno si possa vivere laddove manca amore, riconoscimento dell’altro, qualsiasi minimo gesto o sguardo d’umanità: “il mio dolore […] è l’impegno o l’impressione che Dio mi abbia emarginato dal suo grande sapere”. Dopo il lavaggio mattutino collettivo, spiega ancora lei, “ci allineavano su delle pancacce sordide, accanto a dei finestroni enormi, e lì stavamo a guardare per terra come delle colpevoli, ammazzate dall’indifferenza, senza una parola, un sorriso, un dialogo qualunque. Io avevo sete di verità e non capivo come ero potuta capitare in quell’inferno”. Corpi trattati come quelli di bestie, mentre dietro le grida, gli spasmi e la pesantezza di quelle carni si nascondevano amori, sogni, dolori, tradimenti mai accettati. Mai sopita ribolliva inestinguibile quella “sete di verità”. Una sete soffocata ma in lei divenuta fonte di bellezza, nonostante quella “condanna”, negli anni, proseguì anche fuori dal recinto manicomiale, nelle solitudini del quotidiano: “quando mi sveglio al mattino – scriveva, abbandonata, nella sua casa -, e guardo fuori dalla finestra, e mi sento sola, so che nessuno per quel giorno verrà a trovarmi; che, se vorrò, sarò io che dovrò andare a ‘rompere le balle’ agli altri. E questo mi fa male perché io non voglio infastidire nessuno. Ma a volte la solitudine è una cosa atroce, il silenzio è una cosa insopportabile. In manicomio ci avevano abituati al silenzio. […] Il manicomio non finisce più. È una lunga pesante catena che ti porti fuori”.
…E CIO’ CHE INFERNO NON È
“Ogni gesto che dalla gente comune e sobria viene considerato pazzo coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza che non è stata colta dagli uomini”, scrive Alda Merini per dar voce a una verità altrimenti sepolta. Nel manicomio “il tono lucido del delirio diventava corpo e mistero. L’iniziazione si compiva lì, proprio ai margini della sofferenza più inaudita e noi non avevamo specchi per vedere questo mutamento graduale, ma sapevamo, sentivamo che segretamente avvenivano dei traslati. […] Dentro però io avevo uno scrosciare d’acque gementi, di acque turgide di libertà e profonde. Qualcosa si chiudeva all’esterno ma dentro io rimanevo libera”. Una continua dissanguante tensione inonda le sue giornate, dando senso a un’esistenza, nello sguardo sempre duplice rivolto agli abissi e agli splendori dell’essere. Così lei stessa cerca di esprimerlo: “non avevo intorno che un senso di buio e di incertezza. L’inquietudine era soverchia. Paralizzava persino i movimenti. E ciò nonostante, credo che dentro quel buio avrei trovato una via di uscita”: “avevo fame di cose vere, naturali, primordiali; avevo fame di amore. L’avrebbero mai capito gli altri?”. Questa “fame di amore”, questa capacità – per nulla scontata – di scorgere luce da quelle feritoie insopportabili – la trasfoma in una persona che può amare: “scoprii che i pazzi avevano un nome, un cuore, un senso dell’amore e imparai, sì, proprio lì dentro, imparai ad amare i miei simili”. È la misericordia, così assurda e straniera in quel luogo, e per questa ancor più ammantata di grazia: “una volta un’ammalata mi appioppò un sonoro ceffone. Il mio primo istinto fu quello di renderglielo. Ma poi presi quella vecchia mano e la baciai. La vecchia si mise a piangere”.

L’INTERIORITA’, LO SCRIVERE, LA FEDE
Uno dei grandi doni di Alda Merini – a lei stessa e a tutti noi – è stato quello di riuscire, nella disumanità del ricovero, sempre a conservare uno spazio sacro nella propria anima, un luogo inattaccabile, vivo. È ciò che, in fondo, le ha permesso di sopravvivere in quel pozzo maligno: “il lato più sussurrato, più nascosto, più inatteso, forse più prezioso è però quello meno caro a tutti, perché per tutti io sono una pazza”, sono sue parole. Questo lato recondito è puro “spazio d’amore”, “uno spazio di grande ricerca”. Ricerca e salvezza che, nel suo caso, hanno avuto nell’espressione letteraria un’àncora alla quale aggrapparsi: “grazie alla parola, chi ha scritto queste pagine non è mai stata sopraffatta – scrive Giorgio Manganelli nella prefazione a “L’altra verità” – , ed anzi non è mai stata esclusa dal colloquio con ciò che apparentemente è muto e sordo e cieco; la vocazione salvifica della parola fa sì che il deforme sia, insieme, se stesso e la più mite, indifesa e inattaccabile perfezione della forma”. Com’è lei stessa a esprimere, “lo scrivere può diventare un vizio congenito allorché tiene il luogo di una presenza essenziale, talmente bella e felice da trovare appagamento soltanto in una poesia anomala e anormale, quasi pellegrina”, riflesso pieno di un’anima inquieta fino alla malattia, fra disperazione e desiderio di gioia. “Alle volte – scrive – l’angoscia […] mi diventava così forte che dovevo lasciarmi andare a piangere sopra il cuscino” e dunque aveva “voglia di incontrare una morte scheletrica, che abbia l’armonia del riposo. E dire: ‘Va’, consegnami a Dio. Consegnami a Dio, anima turbinosa e infelice, portata via dal cielo sulla morte tremenda di questa ignobile terra’ ”. Ma proprio in quei momenti “mi aggrappavo terribilmente alla fede”, fino a dover scrivere, in un crescendo di consapevolezza, queste parole: “l’unica identità che io conosco è proprio questa meravigliosa identificazione con Dio. Questa familiarità con Dio. Questo discorso con Dio”, perché “solo Dio ha il potere di disarcionare un’anima”, può far vedere anche a un’anima che ha conosciuto l’inferno, come, nella sua essenza, “niente è funesto e che tutto può muovere al bene”.
Pubblicato su “la Voce di Ferrara-Comacchio” del 25 ottobre 2019
http://lavoce.epaper.digital/it/news
La Voce di Ferrara-Comacchio
———————————————————–
“E’ facile nei fragili di spirito, nei deboli di mente, per un amore che hanno impedito si svolgesse, far nascere un delirio. Il debole di mente continua il suo lavoro, monotonamente si svolgono le giornate, di lui nessuno si occupa, quasi tutti coloro che lo circondano sono davanti a lui superbi e giudicano i sentimenti del debole di mente privi di forza, degni di disattenzione. Non si vuol considerare che i sentimenti sono il più grande ed emozionante mistero, quelli che ci uniscono per un golfo sotterraneo con qualcosa di divino, con un Dio che non abbiamo mai visto ma sappiamo esistere e ci fa paura. Gli umili di mente con Costui di continuo conversano senza saperlo” .
(Mario Tobino, “Le libere donne di Magliano”)
Tag:Alda Merini, Cristianesimo, Letteratura, Malattia mentale, Poesia, Religione



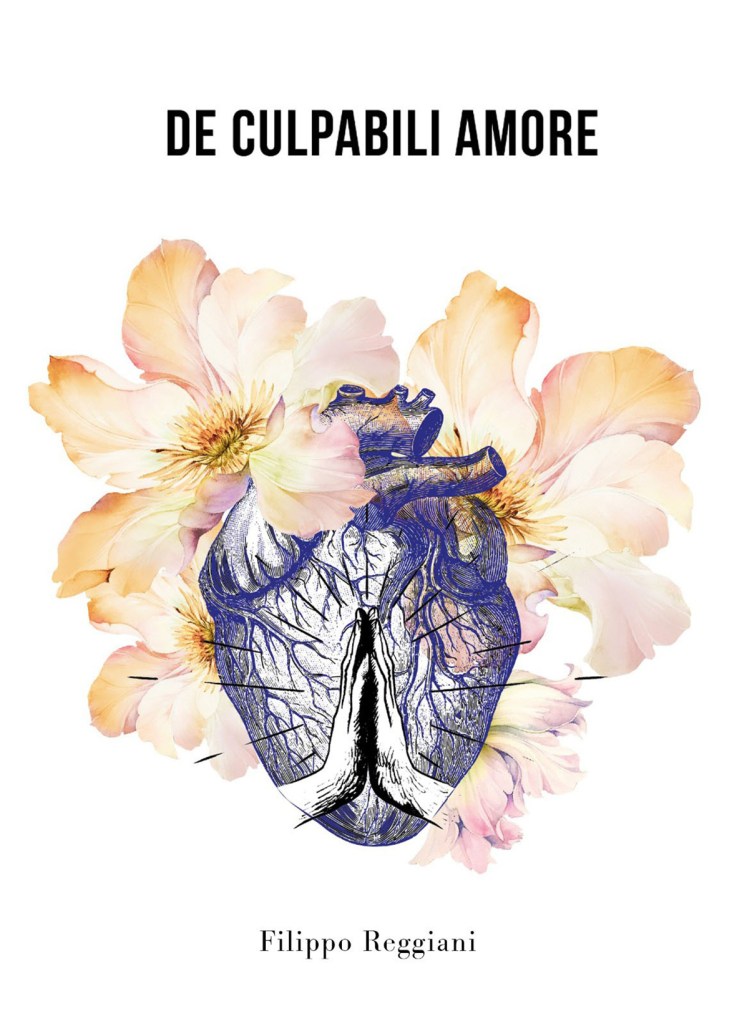






 A cura di Andrea Musacci
A cura di Andrea Musacci “Quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita”: si potrebbe sintetizzare con queste sue parole l’esistenza unica, divina e tremenda, di Alda Merini, deceduta esattamente 10 anni fa, il giorno di Ognissanti. Figlia tanto adorata quanto maltrattata, donna che ha fatto della poesia molto più che una scrittura, un modo di esprimere tanto il delirio e le piaghe interiori quanto quella grazia da lei sempre accolta. Donna afflitta da quello stesso male che la accomunava a Clemente Rebora – vittima, come gli diagnosticarono, di “mania dell’eterno” – e Dino Campana, solo per citarne due. Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano. Il padre Nemo Merini, con lei molto affettuoso, è impiegato di concetto presso le assicurazioni, la madre, Emilia Painelli, è casalinga e donna molto severa. Alda è secondogenita di tre figli, tra Anna, nata il 26 novembre 1926, ed Ezio, nato il 23 gennaio1943. Esordisce come autrice a 15 anni, attraverso un’insegnante delle medie viene presentata ad Angelo Romanò che, apprezzandone le doti letterarie, la mette in contatto con Giacinto Spagnoletti, il quale divenne la sua guida, valorizzandone il talento. Nel 1947, viene per la prima volta internata per un mese nella clinica Villa Turro a Milano, dove le diagnosticano un disturbo bipolare. Spagnoletti sarà il primo a pubblicarla nel 1950, nell’“Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949”. Terminata la difficile relazione con Giorgio Manganelli, il 9 agosto 1953 sposa Ettore Carniti, operaio e sindacalista, in seguito proprietario di alcune panetterie di Milano. Nasce in quello stesso anno la prima figlia, Emanuela, mentre nel ’57 nasce la secondogenita Flavia. Anni dopo, fra il ’64 e il ’72, verrà internata nell’Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”, con alcuni ritorni in famiglia, durante i quali nascono altre due figlie, Barbara e Simona, che saranno affidate ad altre famiglie. Si alterneranno in seguito periodi di salute e malattia, probabilmente dovuti al disturbo bipolare. Nel 1979 riprende a scrivere, dando vita ai testi poi raccolti in “La Terra Santa”. Nel luglio del 1986 fa ricorso al reparto di neurologia dell’Ospedale di Taranto. Nello stesso anno riprende a scrivere e pubblica “L’altra verità. Diario di una diversa”, il suo primo libro in prosa. Soprattutto negli anni 2000 rivive un periodo mistico, dal quale escono diversi libri e antologie di poesie. Muore il 1° novembre 2009, all’età di 78 anni, a causa di un tumore osseo all’Ospedale San Paolo. Dopo l’allestimento della camera ardente, aperta ii giorni successivi, i funerali di Stato sono stati celebrati il 4 novembre nel Duomo di Milano. Oggi Alda Merini è tumulata al Cimitero Monumentale di Milano, nella Cripta del Famedio.
“Quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita”: si potrebbe sintetizzare con queste sue parole l’esistenza unica, divina e tremenda, di Alda Merini, deceduta esattamente 10 anni fa, il giorno di Ognissanti. Figlia tanto adorata quanto maltrattata, donna che ha fatto della poesia molto più che una scrittura, un modo di esprimere tanto il delirio e le piaghe interiori quanto quella grazia da lei sempre accolta. Donna afflitta da quello stesso male che la accomunava a Clemente Rebora – vittima, come gli diagnosticarono, di “mania dell’eterno” – e Dino Campana, solo per citarne due. Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano. Il padre Nemo Merini, con lei molto affettuoso, è impiegato di concetto presso le assicurazioni, la madre, Emilia Painelli, è casalinga e donna molto severa. Alda è secondogenita di tre figli, tra Anna, nata il 26 novembre 1926, ed Ezio, nato il 23 gennaio1943. Esordisce come autrice a 15 anni, attraverso un’insegnante delle medie viene presentata ad Angelo Romanò che, apprezzandone le doti letterarie, la mette in contatto con Giacinto Spagnoletti, il quale divenne la sua guida, valorizzandone il talento. Nel 1947, viene per la prima volta internata per un mese nella clinica Villa Turro a Milano, dove le diagnosticano un disturbo bipolare. Spagnoletti sarà il primo a pubblicarla nel 1950, nell’“Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949”. Terminata la difficile relazione con Giorgio Manganelli, il 9 agosto 1953 sposa Ettore Carniti, operaio e sindacalista, in seguito proprietario di alcune panetterie di Milano. Nasce in quello stesso anno la prima figlia, Emanuela, mentre nel ’57 nasce la secondogenita Flavia. Anni dopo, fra il ’64 e il ’72, verrà internata nell’Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”, con alcuni ritorni in famiglia, durante i quali nascono altre due figlie, Barbara e Simona, che saranno affidate ad altre famiglie. Si alterneranno in seguito periodi di salute e malattia, probabilmente dovuti al disturbo bipolare. Nel 1979 riprende a scrivere, dando vita ai testi poi raccolti in “La Terra Santa”. Nel luglio del 1986 fa ricorso al reparto di neurologia dell’Ospedale di Taranto. Nello stesso anno riprende a scrivere e pubblica “L’altra verità. Diario di una diversa”, il suo primo libro in prosa. Soprattutto negli anni 2000 rivive un periodo mistico, dal quale escono diversi libri e antologie di poesie. Muore il 1° novembre 2009, all’età di 78 anni, a causa di un tumore osseo all’Ospedale San Paolo. Dopo l’allestimento della camera ardente, aperta ii giorni successivi, i funerali di Stato sono stati celebrati il 4 novembre nel Duomo di Milano. Oggi Alda Merini è tumulata al Cimitero Monumentale di Milano, nella Cripta del Famedio.